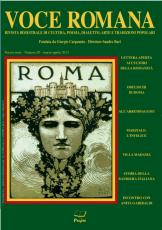
Rivista bimestrale Voce Romana
n° 20 - marzo-aprile 2013
Sulle onde della Storia Romana (II)
All'arrembaggio!
di DOMENICO CARRO

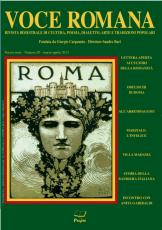 |
Rivista bimestrale Voce Romana
|
 |
Sono purtroppo balzati agli onori della cronaca, per la pretestuosa ed illegale detenzione cui sono stati sottoposti in India, i cosiddetti “due marò”, o più precisamente i due Sottufficiali Fucilieri di Marina del Reggimento S. Marco che facevano parte dei nuclei di protezione che la Marina Militare fa imbarcare sulle navi mercantili italiane in navigazione nell’Oceano Indiano per porle al riparo da ogni tentativo di assalto da parte dei pirati. Ma chi sono questi sorprendenti militari, che si sono imposti all’attenzione dell’opinione pubblica nazionale per la loro fiera e composta imperturbabilità nonostante l’interminabile protrarsi dell’incertezza sulla loro sorte? Molti pensano che si tratti di una sottospecie di marines, come se il loro Reggimento fosse una pallida scimmiottatura italica del tanto strombazzato corpo statunitense. In realtà è avvenuto l’esatto contrario: se l’origine dei marines americani viene fatta risalire al 1775, ad imitazione dell’analogo corpo britannico fondato venti anni prima, in Italia la formale istituzione della fanteria di marina è avvenuta fra il 1550 (i Fanti da Mar della Serenissima) ed il 1713 (il Reggimento La Marina in Sicilia) essendo stata preceduta dal reggimento costituito dal doge Enrico Dandolo all'epoca della quarta crociata ed impiegato per gli sbarchi navali a Costantinopoli (1203-1204).
Ma anche questa è storia recente, perché i veri inventori della fanteria di marina sono stati gli antichi Romani. Prima di essi, le maggiori potenze navali del mondo antico concepivano i combattimenti in mare come delle azioni essenzialmente finalizzate alla distruzione delle navi avversarie mediante lo speronamento. In tale ottica, l’arte della battaglia navale si basava sull’abilità dei comandanti nel far compiere alla propria nave delle repentine evoluzioni tali da schivare i rostri altrui e da portare invece la propria prora rostrata a speronare con la massima possibile potenza la fiancata di una nave nemica. Per tale motivo, le navi da guerra dovevano essere soprattutto veloci e molto manovriere, due qualità che potevano essere ottenute solo con un drastico contenimento dei pesi. Per gli equipaggi, in particolare, non essendo ovviamente possibile rinunciare ad imbarcare tutto il personale necessario per azionare i remi e per le manovre marinaresche, veniva ridotta allo stretto indispensabile la presenza degli uomini armati. Questi ultimi avevano peraltro dei compiti piuttosto limitati, dovendo provvedere al servizio d’ordine in porto ed in navigazione, nonché a fronteggiare qualche improbabile esigenza di difesa in caso di abbordaggio nemico. Coerentemente, solo pochissime decine di fanti (con armatura pesante, come gli opliti dei Greci) venivano imbarcati sulle navi da guerra operanti nel Mediterraneo prima dell’arrivo dei Romani.
Ben diverso fu l’approccio romano alle questioni navali: un approccio saldamente pragmatico, refrattario al futile fascino delle eleganti schermaglie in cui eccellevano i comandanti tradizionali, che combattevano in mare con l’impegno agonistico di un fiorettista in una sfida all’ultimo sangue.
Per i Romani le navi non erano affatto un’arma da duello utilizzabile per esibire la propria superiore abilità nei confronti di un nemico da affondare o da mettere in fuga; le navi erano invece il mezzo indispensabile per affermare la potenza di Roma sul mare ed oltremare. L’obiettivo era quindi il dominio del mare (imperium maris), poiché questo consentiva di inibire gli attacchi nemici contro le proprie coste, di assicurare il regolare afflusso dei rifornimenti vitali trasportati lungo le rotte del traffico marittimo, e di mantenere sempre aperta la possibilità di effettuare degli interventi sulle altre coste ed isole del Mediterraneo.
Per ottenere questo risultato, le navi da guerra dovevano disporre di un robusto contingente di uomini armati pronti al combattimento, sia in mare, contro il naviglio nemico, sia sulle coste ove si rendesse necessario uno sbarco romano. Questi reparti imbarcati potevano essere prelevati direttamente dalle legioni, in mancanza di alternative, ma risultava preferibile ch’essi fossero costituiti prioritariamente da combattenti particolarmente adatti ad operare a bordo in modo protratto e disagiato, anche in condizioni meteomarine alquanto severe. Per tale motivo, nella primissima flotta romana, ingranditasi nel IV secolo a.C. in seguito alla cattura delle navi di Anzio, vennero imbarcati dei fanti forniti dalle alleate città costiere della Campania, cioè da uomini che possedevano fin dall’infanzia una naturale familiarità con il mare e con le navi. Questa scelta estremamente razionale (tanto che un analogo criterio venne seguito fino a pochi anni fa per la nostra leva di mare) si riflesse sull’iniziale denominazione dei combattenti imbarcati sulle navi romane: socii navales, ovvero gli alleati navali.
Va anche detto che questi alleati, pur avendo l’indispensabile “piede marino”, non poterono subito recepire adeguatamente i dettami della disciplina romana. È perlomeno quanto appare dal grottesco epilogo di un’azione dimostrativa condotta nel Golfo di Napoli nel 311 a.C. da parte di una flotta romana comandata dal duumviro navale Publio Cornelio. Sbarcati a Pompei per compiere un’incursione nel territorio di Nocera, i socii navales si dispersero disordinatamente nelle campagne per trarne delle prede, ma vennero poi assaliti dai contadini mentre tornavano indietro alla spicciolata, salvandosi solo in parte dopo una precipitosa fuga fino alle navi.
La fanteria di marina romana assunse una consistenza di rilievo ed una spiccata efficienza da quando i Romani dovettero armare la loro prima grande flotta di quinqueremi nei primi anni della prima guerra Punica. Su ogni quinquereme imbarcava infatti un manipolo (pari a due centurie) di fanti, chiamati da quel momento in poi milites navales, anche se l’antica denominazione continuò ad essere utilizzata come sinonimo, prescindendo dal suo significato anacronistico.
Con questi uomini a bordo, le flotte romane hanno vinto tutte le loro battaglie navali, ad eccezione di una sola (quella persa nel 249 a.C. nelle acque di Trapani per un errore di valutazione del console). Per dare una spiegazione ai perentori successi conseguiti in mare dai Romani contro le flotte delle più esperte potenze navali dell’epoca, gli storici antichi – ad iniziare da quelli greci, che amavano apparire esperti di cose navali – hanno ripetuto fino alla noia che, per compensare la loro scarsa destrezza in mare, gli stessi Romani avevano “trasformato le battaglie navali in battaglie terrestri”: un paradosso che, nonostante la sua fuorviante assurdità, continua ad essere bovinamente ripetuto ancor oggi, come se l’ampio e stabile scenario delle manovre campali delle legioni avesse realmente potuto essere riprodotto sugli angusti tavolati dei ponti di coperta di navi che manovravano freneticamente, rollando e beccheggiando, sferzate dagli spruzzi di mare e lambite dalle fiamme dei principi d’incendio provocati dai proiettili incendiari.
In realtà i Romani non poterono ricorrere a nessun trucco scenico, dovendo inevitabilmente adattarsi alle peculiari caratteristiche dell’ambiente navale ed all’indomabile potenza degli elementi nell’ambiente marittimo. Essi ebbero semplicemente una spiccata propensione per l’arrembaggio, cioè per una delle azioni più marinaresche che si possano effettuare in mare contro un’unità nemica. La manovra, in effetti, era tutt’altro che semplice, poiché occorreva prima di tutto schivare gli attacchi dei rostri nemici, poi portarsi ad affiancare l’unità prescelta, il cui comandante non attendava certo passivamente il tentativo di abbordaggio, ma manovrava violentemente per allontanarsi al più presto. Essendo comunque riusciti ad affiancare la nave nemica, mentre saettavano i dardi e gli altri proiettili scagliati da entrambe le parti, i Romani lanciavano i loro grappini d'abbordaggio, chiamati manus ferreae (mani di ferro), per agganciarli ai bastingaggi ed alarsi sotto fino al completo contatto fra le due fiancate. A quel punto i militi navali balzavano sul ponte di coperta dei nemici ed andavano rapidamente a neutralizzare ogni resistenza fino ad assumere il pieno controllo della nave arrembata, catturandola insieme al relativo equipaggio ed ai beni trasportati. Si trattava, nel complesso, di un bottino di elevato valore, che giustificava ampiamente la predilezione romana per l’arrembaggio rispetto allo speronamento.
Tale era dunque, in poche parole, il ruolo principale dei militi navali romani nella fase più calda di una battaglia navale. Questi uomini avevano comunque molti altri compiti, sia a bordo (ove erano addetti a tutte le armi, alle macchine belliche ed alle torri di combattimento), sia negli sbarchi navali e nelle susseguenti azioni terresti. Ma le loro operazioni anfibie e sulla terraferma saranno oggetto di uno dei successivi articoli. Qui dovrebbe bastare aver introdotto l’argomento, mostrando come questi reparti di milites navales (che saranno poi chiamati classiarii in epoca imperiale) siano stati in tutto e per tutto la prima vera e propria fanteria di marina, intesa in senso moderno, e quanto essi abbiano contribuito alle plurisecolari vittorie navali di Roma.
© 2013 - Proprietà letteraria di DOMENICO CARRO.
